
STANZA 324
Il rumore della porta sbattuta sta ancora vibrando nel mio stomaco, così come la sua voce: acuta, stridente, feroce.
«Finiscila di starmi addosso, mamma! Mi hai rotto le palle!».
Fisso inebetita la parete di fronte a me senza vedere niente. Cerco di controllare la rabbia e il dolore. Cerco di controllare il senso di impotenza e disperazione. Cerco di controllare il desiderio di seguirla fuori dalla stanza e prenderla a sberle anche se siamo in albergo e l’ultima cosa di cui abbiamo entrambe bisogno è dare spettacolo. Cerco di controllare la voglia di spaccare tutto quello che ho intorno e mi concentro sulla stampa che c’è appesa alla parete di fianco al letto. Due orribili volti di donna – ironia della sorte, madre e figlia, lo dice anche il titolo scritto sotto – mi fissano con espressione arcigna. Sembra dipinto da un Andy Wharol dei poveri fatto di crack.
Tremo. Questo non riesco a farlo: controllare il tremore che mi percorre il corpo. Non sono nemmeno in grado di reggere il bicchiere d’acqua che devo posare sul comodino per non farlo cadere a terra. Ci ho provato, ma non riesco a tenerlo in mano. Di alzarmi, per ora, non se ne parla.
Non ricordo nemmeno più come è iniziata questa lite, l’ennesima. Per un motivo stupido, di certo. Come capita sempre più spesso. Qualcosa che non vuole mangiare, o una camicia che non le ho stirato, o perché le ho detto di non stare le ore al cellulare, o perché si annoia… non lo me lo ricordo. Iniziano tutte nello stesso modo le nostre discussioni, per degenerare in liti furibonde nel giro di pochi minuti. Come una palla di neve che diventa valanga mano a mano che scende verso valle.
È la sua rabbia ad annientarmi. È il modo in cui mi guarda quando comincia ad alterarsi. Dentro i suoi occhi di diciassettenne c’è un sentimento che non dovrebbe esserci: odio. Le accende lo sguardo, la stravolge. Quando mi guarda così è come se invecchiasse di colpo. Una ragazza della sua età anni non dovrebbe nemmeno sapere cos’è l’odio, eppure è inequivocabile ciò che vedo.
Lei l’odio e il dolore, io la rabbia e l’impotenza.
Tutto è cominciato il giorno in cui suo padre se n’è andato, otto anni fa.
«È finita», mi aveva detto reggendo il televisore che gli serviva per arredare il nuovo appartamento. Io lo guardavo interdetta. Sapevo che era finita. Lo sapevo da tempo. Sapevo che c’era un’altra. C’è quasi sempre qualcun altro in fondo al vicolo di una storia d’amore. Sapevo che non mi amava più. Sapevo che non lo amavo più. Sapevo tutto, eppure non avevo mai voluto guardare davvero. Andavo avanti per forza d’inerzia raccontandomi una montagna di bugie. “È un periodo di crisi passeggero”, “Siamo stanchi per il troppo lavoro per questo non ci tocchiamo nemmeno più”, “Tutte le coppie sposate da tanti anni come noi attraversano momenti difficili”, e così via. Intanto il matrimonio andava alla deriva e io fingevo di non vederlo. Alice, invece, vedeva tutto. Una bambina di sette anni che guardava i suoi genitori distruggersi a colpi di frasi feroci, ripicche, liti furibonde. Lei, così legata a suo padre, lo ha visto andarsene senza poter fare niente.
Pochi giorni fa me lo ha urlato in faccia: «È stata colpa tua se papà se n’è andato»!. Avrei voluto risponderle che suo padre mi tradiva da anni con quella che ora è la madre di suoi due altri figli, ma non ho detto niente, perché sono certa che Alice, in fondo, lo sa. Solo che non riesce ad ammetterlo. Non riesce ad ammettere che suo padre non è l’uomo perfetto che ha sempre creduto fosse.
Dal bagno dove si è rinchiusa arriva una musica martellante a tutto volume. L’idea di alzarmi per andare a cercarla mi fa stare male.
Alice, appena varcata la soglia dell’albergo, ha sentenziato: «È pieno di vecchi». E lì ho capito che non ci sarebbe stata tregua.
Non ho più la forza di affrontarla. Di guardare di nuovo nei suoi occhi quei lampi di rabbia così assoluta.
Seduta su una delle due sedie della stanza incrocio le braccia e le appoggio sul tavolo, come quando andavo a scuola e ci facevano fare un quarto d’ora di riposino. Abbandono la testa sulle braccia e resto lì, immobile, gli occhi chiusi, il respiro che lentamente torna normale. Vorrei riuscire ad addormentarmi, per alcuni giorni, alcuni mesi, poi svegliarmi e vedere che tutto è passato, che Alice mi vuole bene come quando era bambina e non poteva stare lontano da me.
Mi tornano alcune immagini di lei che corre verso la giostra in un giorno d’estate. Eravamo al mare, tutti e tre. Io, lei, suo padre, felici, di quella felicità un po’ stupida, fatta di gelati comperati al chiosco in riva al mare, di lunghe camminate sulla spiaggia, di ore stesi al sole senza parlare ma appagati della presenza dell’altro. Io e suo padre ci ritrovavamo spesso a guardarla, Alice, che se ne trotterellava in giro, paffuta, con i suoi boccoli scuri che le scendevano ribelli sulle spalle, gli occhi in cerca di chissà quale meraviglia.
Alzo un poco la testa e mi guardo intorno. Il disordine che c’è in questa stanza luminosa ed estranea, mi opprime. Mi sembra di essere incapace di fare qualunque cosa, anche solo di spostare un vestito, aprire una valigia, sistemare le creme in bagno.
La musica mi sta penetrando nella testa, nelle ossa, mi scuote, mi stringe lo stomaco. Di nuovo percepisco la rabbia dilagare in tutto il corpo. Un desiderio incontrollabile di uscire, andare a cercare suo padre e portarlo qui e urlargli: “Guarda! Guarda cos’hai fatto! Ci hai abbandonate e ora è tutto distrutto!”.
Riappoggio la fronte sulle braccia e cerco di calmarmi. Non è stata solo colpa sua. Non riesco neanche a pronunciare il suo nome. Giorgio. Giorgio. Il mio ex marito si chiama Giorgio, mi ripeto. E non è stata solo colpa sua se il nostro matrimonio è andato in pezzi. Non so perché è successo, ma è successo. Un giorno, semplicemente, abbiamo smesso di amarci. Per molto tempo mi sono raccontata che era colpa dell’altra, ma dentro di me ho sempre saputo che non era vero. Lei è arrivata dopo, quando della nostra unione non era rimasto niente se non la forma. Di sostanza non ce n’era più da tempo. Perché è successo? Non lo so, giuro che non lo so. Forse abbiamo dato per scontate troppe cose e non abbiamo più cercato lo stupore dell’essere insieme, del vivere insieme.
Ho tutta una serie di immagini indelebili nella mia mente. Momenti trascorsi con lui che sembravano unici e soprattutto infiniti. Ci siamo amati moltissimo, in modo disarmato e disarmante. Ci conoscevamo da quando eravamo adolescenti e abbiamo rappresentato l’uno il grande amore dell’altra. Per molto tempo. La nascita di Alice è stato il momento più alto del nostro amore. La perfezione. E poi. E poi tutto ha cominciato a franare.
D’improvviso, sento che qualcosa è cambiato. Alzo di scatto la testa e mi guardo attorno. Il disordine è lo stesso. Nessuna fata è magicamente comparsa per riassettare il tutto.
I vestiti sono sparpagliati sul letto, le scarpe buttate in un angolo, gli asciugamani formano una pila morbida e sbilenca sull’altra sedia. Basterebbe un niente per farla crollare. Spesso basta pochissimo per far crollare le cose.
Eppure qualcosa è cambiato. Impiego alcuni secondi per capire. È il silenzio. Ora c’è silenzio. La musica assordante è cessata di colpo e un silenzio irreale ha preso possesso della stanza. Raddrizzo la schiena, all’erta come un animale che fiuta un pericolo, ma ancora non sa individuare di cosa si tratti.
«Alice?» azzardo. La mia voce è roca, come se fossi stata zitta per molto tempo. O avessi urlato troppo.
Niente. Non arriva alcuna risposta.
Mi costringo ad alzarmi. Mi sento le gambe pesanti, i piedi ancorati a terra. Muovo un passo. Una fatica immane, come spostare una montagna.
«Alice?» ripeto, il tono di voce più fermo.
Mi risponde lo stesso silenzio di prima. Un silenzio che si mangia tutto: pareti, sedie, tavoli, poltrone, quadri, tappeti, piante, soprammobili. Si inghiotte in un boccone anche me.
Mi precipito verso il bagno, sicura di trovare la porta chiusa a chiave. Invece è aperta e per un secondo questo particolare mi getta nel terrore.
Questo silenzio è Stonato. Distorto. Sbagliato.
Apro con cautela ed entro. Poi la vedo.
Seduta sul bordo della vasca, aggrappata alla radio che le avevamo regalato un Natale di un’altra vita, se ne sta lì, piccola, piccolissima.
Guardo le sue spalle sussultare.
Non alza la testa. Non mi accoglie con il solito sguardo pieno di rancore e sfida. Sta così, seduta in bilico.
Di colpo, mi pervade una calma irreale, come se qualcuno avesse liberato il mio corpo da tutte le paure del mondo.
Quella è la mia bambina.
E ha bisogno di me.
Lo so.
Mi avvicino piano e mi siedo accanto a lei. Allungo una mano e le accarezzo la testa, piano piano, proprio come facevo quando era bambina, per farla addormentare. Lei si volta di scatto e lascia cadere la radio che fa un sinistro crack. Poi mi abbraccia fortissimo. Sento sul collo il caldo delle sue lacrime. Piange a dirotto. Parla e piange. Non capisco bene cosa dice. Qualcosa come: «Scusa mamma… stanca… paura… sola… papà».
Non capisco il senso delle parole, ma ne percepisco il peso, la richiesta, la disperazione.
L’abbraccio più forte e sussurro: «Sssssh, piccolina. Sssssh, c’è la mamma qui con te. Andrà tutto bene. Sta’ tranquilla».
«Lo hai visto?», mi chiede dopo un po’, senza alzare la testa.
«Cosa?».
«Quell’affare appeso di là».
«Eh, sì…».
Ora alza il viso, le lacrime continuano a scendere ma adesso sta sorridendo.
«È terrificante».
Scoppio a ridere e quasi mi commuovo perché scopro di esserne ancora capace.
«Sì», le riesco a rispondere, con le lacrime agli occhi.
«Ce lo portiamo a casa?».
«Come no… ».
«Parlo sul serio».
La guardo. Sì, fa sul serio lo capisco dal tono della voce e dallo sguardo.
«Intendi rubarlo?».
Lei fa sì.
«Tu sei matta. Mica si può», le rispondo abbracciandola.
Lei non si scosta come sempre ha fatto in questi ultimi tempi.
E in quell’istante comincio a pensare a dove infilare quell’orrore, prima di andarcene da qui.
Il Moba (Museum of bad art) esiste: http://www.repubblica.it/2006/08/gallerie/spettacoliecultura/museo-orrori/1.html
© Barbara Garlaschelli, 2018
La sua ultima pubblicazione. Se siete interessati potete contattare l’autrice o andare qui
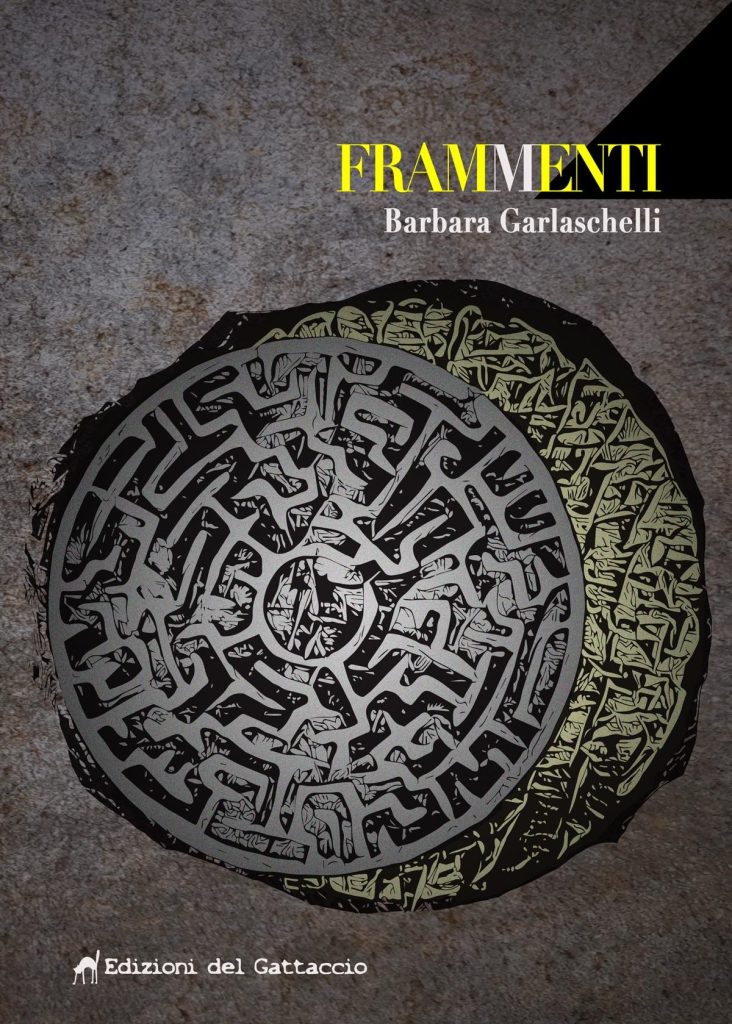
Cover di Raffaele Rutigliano